Film da rivedere: Cruising di William Friedkin
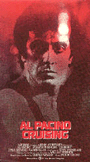
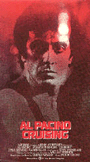 E’ davvero difficile poter condividere anche per poco l’incondizionato entusiasmo mostrato da taluni critici per un autore come William Friedkin, regista orgogliosamente reazionario e di genere: sembra proprio che i due aggettivi, per chissà quale alchimia, si scoprano sinonimi, non perché tutto il cinema di genere sia appunto reazionario, ma perché esso è diventato una bandiera di quanti si definiscono tali. C’è chi è arrivato perfino a fare l’apologia di John Milius per le sue forti capacità di narrare storie, forse dimenticando che Alba rossa è certamente il film americano più ignobile dopo Berretti verdi.
E’ davvero difficile poter condividere anche per poco l’incondizionato entusiasmo mostrato da taluni critici per un autore come William Friedkin, regista orgogliosamente reazionario e di genere: sembra proprio che i due aggettivi, per chissà quale alchimia, si scoprano sinonimi, non perché tutto il cinema di genere sia appunto reazionario, ma perché esso è diventato una bandiera di quanti si definiscono tali. C’è chi è arrivato perfino a fare l’apologia di John Milius per le sue forti capacità di narrare storie, forse dimenticando che Alba rossa è certamente il film americano più ignobile dopo Berretti verdi.
Di Friedkin apprezzammo in passato le doti di abile artigiano capace di immergersi nella frenesia urbana del noir (The french connection) come nel climax terrificante del demoniaco L’esorcista, la cui nuova versione non ha destato l’impressione che si attendeva.
Tuttavia ci sembra difficile sostenere che Vivere e morire a Los Angeles possa essere il capolavoro che molti con tanta fede dichiarano, seguitando a “curare la loro destra”, quasi che in essa vi sia una sorta di spirito profetico di catastrofe morale, di perdita di un’identità nazionale (come già annunciava un John Ford cinico e sconsolato!).
Innanzitutto Cruising sembra proprio il tardo remake de Il braccio violento della legge, con quell’inseguimento in contromano spettacolare e molto celebrato, al pari forse del discreto Ronin di un altro artigiano di Hollywood, John Frankenheimer, sebbene vi sia introdotta una figura più complessa, quella dell’artista spacciatore (Dafoe) che tuttavia nulla toglie al manicheismo di fondo, a quel gusto del binomio giustizia-vendetta proprio di questo cinema, quasi sempre privo di autoironia.
Nella filmografia di Friedkin, Cruising (1980) si impone come un’eccezione. Innanzitutto per l’essenza di una verità manichea. Dietro l’apparente struttura poliziesca, retta sull’indagine, sull’ambiente e sul personaggio, il poliziotto (Pacino), si nasconde invece una indagine più profonda, quella dell’io del protagonista, la cui “avventura” nel mondo oscuro dei gay duri newyorkesi (ottima la descrizione degli ambienti notturni contrappuntata dal ritmo incalzante della musica di Jack Nitzsche) porta si a un colpevole (lo studente universitario impotente, ossessionato dal ricordo del padre autoritario), ma soprattutto ad una verità che sfugge perfino al suo stesso controllo. Privo di qualsiasi formula giustizialista, il film di Friedkin (non a caso il meno amato dai puristi appassionati dell’autore come si deduce dalla monografia di Daniela Catella – 1997) è interamente giocato sul senso d’ambiguità che pervade il rapporto tra il poliziotto e i suoi simili, laddove esiste solo la certezza dei crimini di un assassino (anch’essa negata poi da un nuovo delitto, compiuto dopo la cattura del giovane serial killer che suole ripetere prima di ogni omicidio: “chi ha paura del lupo cattivo?”). Sessualità e onore sono oramai territori incerti nella metropoli newyorkese, senza tuttavia il dovuto compianto del moralista.
Lo sguardo di Al Pacino in piedi di fronte allo specchio a casa della fidanzata mentre essa si prova il suo cappello da poliziotto è un’icona emblematica degli anni sessanta.
di Maurizio Fantoni Minnella